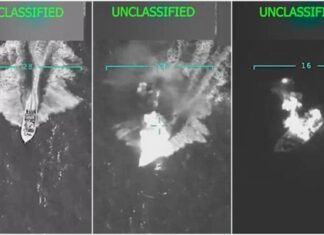Era stata una settimana da incubo per le destre europee, che al Vertice europeo del 27 e 28 giugno avevano subito la plateale umiliazione delle decisioni sulle nomine ai vertici delle istituzio
i Ue prese senza neppure coinvolgerle, a cominciare dalla premier italiana Giorgia Meloni. Inoltre, nell’attesa della prima sessione a metà luglio del Parlamento europeo uscito dalle elezioni dal 6 al 9 giugno, le destre non solo non trovano la coesione tra i gruppi esistenti, i conservatori di Fratelli d’Italia e delle destra polacca, e i sovranisti xenofobi di Identità e Democrazia di Marine Le Pen e Matteo Salvini, ma rischiano di vedere nascere nell’Assemblea un altro gruppo concorrenziale, coagulato intorno al premier ungherese Viktor Orban. Le manovre sono in corso e gli assetti sono mobili.
Poi, è arrivata la domenica del primo turno del voto francese. E, per la Francia, e per l’Europa, è cominciata una settimana di passione: sulla graticola, adesso, sono il centro e le sinistre. I risultati del primo turno delle elezioni francesi lasciano largamente indeterminata la composizione dell’Assemblea nazionale, perché i seggi già assegnati sono circa un sesto dei 577 complessivi (maggioranza assoluta: 289 seggi) e perché il meccanismo del ballottaggio fa sì che la percentuale dei suffragi ricevuti non corrisponda ai seggi ottenuti.
Ma, di sicuro, l’esito del primo turno galvanizza la destra francese e rafforza quella europea. Anche se, nei confronti del Rassemblement National di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, dovesse funzionare il cordone sanitario della Francia ‘républicaine’, cioè la reciproca desistenza dei candidati del centro del presidente Emmanuel Macron e del Front National di sinistra a favore del meglio piazzato nei ballottaggi a tre, che sono molto numerosi – vi accendono quanti ottengono almeno il 12,5% dei votanti potenziali, non dei votanti effettivi -.
L’ ‘esprit républicain’ ha finora sempre funzionato in Francia, nelle presidenziali e nelle politiche. Ma, questa volta, le incognite sono maggiori, perché il sostegno al RN è molto forte, perché una fetta della destra tradizionale potrebbe votare i candidati lepenisti e perché la coesione fra Macron e i leader del FP è labile – ed a livello di elettori è più labile ancora –. Del resto, la stessa coesione nel FP è labile.
Ue: nomine, riflessi europei dei risultati francesi

I risultati francesi hanno riflessi europei. Non possono rimettere in discussione gli accordi già fatti sulle nomine al vertice delle istituzioni, ma possono aumentare la capacità di attrazione delle destre nel Parlamento europeo e il loro peso nel Consiglio europeo, specie se la Francia avrà un governo e un premier di estrema destra. Il che, di per sé, sarà sufficiente a incrinare l’asse franco-tedesco, tradizionale motore dell’integrazione europea e punto d’intesa necessario di ogni decisione, uscito già indebolito dalle elezioni europee, uno smacco per Macron e per il cancelliere Olaf Scholz.
Suggellata da un patto fra popolari, socialisti e liberali, l’intesa sulle nomine era stata concordata prima del Consiglio europeo della scorsa settimana ed è poi stata formalmente confermata dai capi di stato e di governo. Essa prevede: Ursula von der Leyen, popolare, tedesca, confermata a capo della Commissione europea; Antonio Costa, socialista, portoghese, alla presidenza del Consiglio; Kaje Kallas, liberale, premier estone, a guida della diplomazia europea. La presidenza dell’Assemblea è decisione che spetta agli eurodeputati, ma l’accordo prevede che Roberta Metsola, popolare, maltese, sia confermata nel suo ruolo.
I capi di Stato e/o di governo popolari, socialisti e liberali, nell’attuale Consiglio europeo, fanno maggioranza qualificata: sono 15 su 27 e rappresentano più del 65% della popolazione totale. Possono, quindi, decidere senza ulteriori apporti.
Ue: nomine, il ruolo e le stizze dei Giorgia Meloni

I toni stizziti della premier Meloni nel criticare, in Parlamento a Roma e in Consiglio a Bruxelles, le nomine europee confermano che l’Italia non ha avuto parte attiva nel negoziato, condotto dai leader greco e polacco per il Ppe, tedesco e spagnolo per il Pse e francese e olandese per i liberali. E’ stato il canto del cigno europeo del premier olandese Mark Rutte: designato segretario generale dell’Alleanza atlantica – incarico che assumerà il 2 ottobre -, dopo quasi 14 anni è stato avvicendato in Olanda il 2 luglio da Dick Schoof.
Dalla trattativa sulle nomine, Meloni e gli altri – pochi – leader europei di destra, sovranisti o nazionalisti, o alfieri della ossimorica ‘democrazia illiberale’, sono stati dunque esclusi. Come risposta, Meloni ha votato contro l’intesa, criticando metodo – oggettivamente discutibile – e merito delle scelte fatte e astenendosi solo su von der Leyen, con cui ha apparentemente costruito un buon rapporto personale.
Ma le decisioni rispecchiano i risultati delle elezioni europee, che hanno confermato – e rafforzato – i popolari prima forza dell’Assemblea di Strasburgo e i socialisti, rimasti seconda, pur se leggermente indeboliti. Con i liberali, che hanno però perso peso, formano una maggioranza ‘europeista’ abbastanza ampia: circa 400 seggi, rispetto ai 361 necessari.
Subito dopo le elezioni europee, era parsa palese la volontà dei leader, specie il presidente Macron e il cancelliere Scholz, di stringere i tempi delle nomine, senza attendere le politiche francesi che potevano produrre un quadro negoziale più complicato e indebolirli ulteriormente, com’è successo. Parlando al Bundestag, Scholz spiegava: “Tre tedeschi su quattro e tre europei su quattro non sono per i populisti… Perciò mi sono impegnato perché la Commissione non dipenda dai populisti”.
Von der Leyen dovrà ottenere l’investitura del Parlamento europeo, già nella prima sessione dell’Assemblea dal 16 al 19 luglio. Costa e Kallas sono nomine dirette del Consiglio europeo (ma Kallas dovrà ricevere l’approvazione degli eurodeputati, in quanto membro della Commissione).
Uvdl, consapevole del rischio di franchi tiratori nella sua maggioranza, proverà ad allargare l’area del consenso sul suo nome, magari con i conservatori (o direttamente con Fratelli d’Italia), capitalizzando l’intesa con Meloni ostentata negli ultimi mesi. Il votare l’investitura non garantisce, però, di contare nella legislatura prossima ventura: nel 2019, Cinque Stelle le diedero i loro voti indispensabili, ma non me ricavarono poi il minimo beneficio operativo o politico.
Qui s’inserisce la trattativa sugli incarichi dei membri della Commissione: l’Italia, come ogni Paese Ue, può indicare un commissario ed è quasi ovvio che, essendo l’Italia uno dei Grandi dell’Ue, questi abbia un portafoglio importante e/o una vice-presidenza. Difficile, quindi, vantare come successo un risultato del genere: non è mai successo che l’Italia avesse un dossier marginale e non avesse una vice-presidenza.