Giorgia Meloni. Partenza cauta
Senza dover scomodare The Economist[1], in tutta modestia, anche noi, sulle pagine di questa rivista che gronda storia antifascista, qualche spunto di attenzione serena alla discontinuità politica e istituzionale di questo governo minoritario nel Paese ma maggioritario in Parlamento, l’avevamo scritta e riscritta dal settembre del 2022 in poi.
Queste attenzioni su Giorgia Meloni non sono quelle – un po’ ovvie – di colore. Non è colore dire “una donna giovane” a Palazzo Chigi. È colore ricamare sul decisionismo, sulla retorica assertiva, sulla psicologia dell’assediato. Così al levarsi di un’idea di rilancio, nell’Europa che ignora la matrice africana della propria esistenza, di una politica dialogante e non di rapina con l’Africa, idea connotata con le parole “Piano Mattei” (uno dei sostenitori del primo centrosinistra per favorire l’allentamento italiano dallo schieramento della guerra fredda) di per sé non è giusto alzare scudi di disprezzo.
Così come attorno allo spunto di una didattica intermedia per dare spessore alla formazione delle professioni creative, pur con la disinvolta etichetta di ‘Made in Italy’, non è giusto parlare solo di propaganda ideologica.
E, malgrado l’imposizione ossessiva della parola “nazione” – che andrebbe utilizzata quando si parla della dimensione istituzionale della comunità, meno quando si parla della dimensione socio-culturale e meno ancora quando si parla di relazione economica pubblico-privata (tanto che qui l’espressione internazionale è “Sistema-Paese”) – si può aprire un dialogo, appunto, sulle corrette ricadute dei termini. Persino sulla parola “patria”, parte dell’antico vocabolario mazziniano e risorgimentale della sinistra italiana, non c’è da entrare in escandescenze solo perché quella sinistra post-risorgimentale si è dimenticata di sé stessa.
Infine, anche l’appello all’interesse della Nazione conserverebbe una sua ragione. Malgrado la sottolineatura martellante che finisce per riprodurre il carattere enfatico di una storica propaganda. Tuttavia, l’espressione connota una ragione di governo, di qualunque governo. Perché l’eccesso di ‘particularismo’, il “tengo famiglia”, la metafora crozziana dell’italiano a somiglianza del senatore Razzi, costituiscono l’immenso armamentario della fragilità sistemica degli italiani travasata sullo scarso senso dello Stato inteso come patologia dell’Italia.
Nella prima analisi della cultura politica espressa dal successo elettorale di Giorgia Meloni, fatta su questa rivista, segnalai l’opinione di Paolo Pombeni, che offriva un paradigma di giudizio più complesso di quello al momento invalso[2] che resta aperto al giudizio anche oggi, con qualche argomento di valutazione più consolidato:
“Se Meloni riuscirà davvero a gestire un nuovo contesto, avrà aperto, grazie, non lo si dimentichi, al lavoro fatto da quel servitore delle istituzioni che è stato Mario Draghi, finalmente una stagione di alternanza politica fra la destra e la sinistra, che si scambiano i ruoli nel considerare con approcci diversi problemi che riconoscono come comuni (ovviamente passando per confronti elettorali organizzati da leggi che non siano pastrocchi come quella attuale). Altrimenti avremo avuto, non sappiamo per quanto tempo, un altro episodio del succedersi di alternative che cancellandosi a vicenda non fanno mai fare al paese alcun vero passo avanti”.
Nazione, un’arma a strappo usata contro avversari e alleati
Tutto questo per dire che l’approccio culturale di un’alleanza di governo che vuole disputare la sua partita a partire dalla rigenerazione di una prospettiva storica delle nostre narrative identitarie, non è di per sé cosa da liquidare come sindrome neofascista senza fare lo sforzo di entrare nel merito, valutare linguaggi e propositi, misurare spessore o superficialità delle intenzioni e del trattamento. Una linea che, per prima cosa, appare non come cornice di un progetto di alleanza di governo ma come caratterizzazione del partito di maggioranza, a strappo e anche in contraddizione con i suoi alleati. Uno dei quali fonda le sue radici sulle autonomie dei territori in chiave anti-nazionale e l’altro si richiama all’accoglienza europeistica e popolare dei propri principi identitari.
La misura della durata del governo e quindi della casistica di eventi – alcuni con rilievo materiale, altri di natura più simbolica – costituisce un fondamento per poter giudicare senza remore e compiutamente, natura, pregi e limiti dei governi della storia repubblicana, quasi tutti collocati in durate brevi. Dunque, non c’è bisogno di aspettare altro per applicare un paradigma a ciò che in sedici mesi costituisce “percorso” e non “casualità”.
L’adozione di un progetto di identità collettiva fondato sulla parola “Nazione” è attraversato da spunti legittimi. Ma alla fine essi determinano un perimetro concettuale che, per sostanza e trattamento, identifica una cultura politica, di conseguenza un tratto ideologico che costruisce una architettura e una linea immaginaria che, malgrado le trasformazioni, è ancora legittimo considerare appartenente alla sinistra, alla destra o ai tratti intermedi che si riferiscono a quella polarità.
La forte determinazione del partito di maggioranza relativa che guida l’alleanza di governo di rivendicare l’appartenenza a destra di tale guida (con una formula di centro-destra ridefinita di destra-centro) fa così riconoscere che c’è anche una scala europea che misura il concetto di Nazione.
Per il partito di Giorgia Meloni esso è il principale identificativo della cultura di governo. Ciò significa che è parte di uno schieramento europeo che rivendica il nazionalismo come storia di riferimento e il sovranismo come scelta che precede la tensione esistente a concepire in movimento un’altra storia. Diciamo, semplificando, che l’altra storia è quella della necessità di una progressiva integrazione europea e di riportare a una matrice federalista il rapporto tra tutte le identità territoriali come parte non di schemi nazionali contrapposti ma di progetti di governo e di riforma sorretti dal principio che in Europa si chiama multi level governance. Questa polarizzazione sarà anche quella che finirà per esprimere i due versanti dell’elettorato europeo in occasione del turno di giugno, configurando queste come le due macro-aree politiche dell’Europa.
Europa, il terreno dell’inevitabile contraddizione
Si potrebbe a questo punto obiettare che, pur con elementi di ripresa e qualche indicatore in agenda per ridare speranze di prospettiva, i fattori della crescita italiana sono ancora deboli. Come accade per più di mezza Europa. Così da dover ammettere che – al di là dello scontro politico-ideologico – è proprio tra le forze produttive italiane che covano attualmente istanze protezionistiche. Le quali finiscono per alimentare un’offerta politica ispirata al controllo dei confini interni dell’Europa e all’applicazione di riduttori regolamentativi alla concorrenza. Per lo meno fino a che le curve di crescita tornino a rivelare un irrobustimento ineludibile.
Anche fosse questo il clima che il governo intenda cavalcare – compenetrato in questa analisi delle pressioni interne – la dichiarazione di appartenenza allo schema nazionalistico-protezionista-sovranista colloca i partiti che alzano questa bandiera tendenzialmente fuori dall’area di maggioranza probabile che si appresta a guidare l’Europa. Maggioranza a cui la premier italiana da spesso segnali di voler appartenere, certo ampliando e modificando il senso dell’attuale maggioranza.
Insomma, attorno al concetto di Nazione si verrebbe a profilare un doppio posizionamento tra contesto italiano ed europeo (doppio linguaggio, doppia narrativa, doppio paradigma di scelta).
All’interno, scenario di antiche battaglie, preme l’obiettivo strategico di demolire l’idea gramsciana di Paese. Verso l’esterno si conferma l’idea di mantenere una ferma opposizione al globalismo anti-nazionalistico e di essere contro altri conferimenti di sovranità all’Europa. Salvo poi far passare la logica che il sistema di alleanze necessarie per la tutela internazionale dell’Italia permetta di ipotizzare cessioni di sovranità militare assecondando l’appartenenza Nato e anche cessione di sovranità finanziaria e di bilancio per rispettare il principio di governare insieme il rischio di non contaminazione di crisi finanziarie.
Lo slalom si profila così: equilibrismo in Europa e riallineamento interno a codici culturali che permettano al partito di maggioranza relativa di contendere meglio l’occupazione dei posti di sottogoverno in nome della legittimità di assumere il pieno controllo dell’apparato economico-culturale pubblico. Un riequilibrio legittimo – dicono gli esponenti di Fratelli d’Italia – attraverso un contrattacco egemonico deciso dagli elettori e rivendicato dopo settant’anni di
“egemonia esercitata dalla sinistra in campo culturale ed esercitata dalla cultura liberale in campo finanziario”.
È su questo terreno che si pianta la bandiera conquistata con l’esito elettorale. Marginalizzare il post-comunismo (in gergo chiamato “la sinistra”) abbarbicato sull’antifascismo considerato “di maniera” e il post-capitalismo consegnato agli interessi multinazionali (con la loro alleanza raccontata come filone di intrecci nella seconda Repubblica). Giusto quella bandiera della Nazione, che finalmente può essere agitata anche recuperando la mitologia risorgimentale (Mazzini–Garibaldi) dimenticata dalla sinistra e recuperando i paladini dell’Italia proletaria contro le demo-pluto-giudo-democrazie con altro genere di bandiere dismesse come quella di Enrico Mattei.
Mentre la bussola degli orientamenti europei di Giorgia Meloni, tra il suo partito italiano e il suo gruppo europeo, è ancora negoziale e ondivaga. Restando comunque frequente la cronaca di episodi in cui l’interesse identitario italiano viene strumentalizzato per altri scopi mescolando azione di partito e azione di governo. Così come quando Giorgia Meloni sceglie Budapest per rilanciare il nesso “Dio, Patria, Famiglia”, nesso che fa riferimento a un segmento forte del suo elettorato, il quale tuttavia, data l’astensione, arriva appena al 15 per cento degli italiani. Finendo per ridurre anche a cifre minoritarie il peso e la rappresentanza dell’interesse nazionale raccontato da Fratelli d’Italia[3].
Ma anche le derive globali possono produrre lo schianto
La doppiezza della “linea” non è una novità nella storia politica italiana. Ci sono stati tempi in cui essa era persino dottrina di partito (riferimento al togliattismo). E ci sono state figure rilevanti dello scenario politico italiano che trasformavamo doppiezze in nebulose complessità. Come i disegni di alleanze con reconditi significati di cui fu specialista Aldo Moro che illanguidiva ogni avversario nelle sue piste parallele all’infinito. Ma quella tecnica di rapporto prima con i socialisti (anni Sessanta) e poi con i comunisti (anni Settanta) richiede una retorica lenta, lucida, dialogante, estenuante, che apparteneva appunto al leader della DC. Sarebbe stata impraticabile con le sciabolate continue assertive e bellicose che Giorgia Meloni non depone mai, che la portano tendenzialmente a conflitti e ad incrociare prima o poi la contraddizione esplosiva.
L’impalcatura della restaurazione del concetto di Nazione ha dunque due teatri di recitazione: in Italia è più ideologico, in Europa più camuffato. Così quel concetto diventa un po’ opportunistico. Serve allo spartito di chi è finora opposizione in Europa. Ma non stimola la capacità di governo che servirebbe per spingere riforme e trasformazioni in Italia. In particolare, dopo il “cantiere Draghi” si rivelerebbe prezioso un governo negoziale alimentato da un ceto politico capace di mettere a fuoco strumenti di analisi e di proposta adatti al terzo millennio. L’anno e mezzo di governo Meloni tende a restaurare architetture culturali e comunicative che suonano ancora remote sia per le storie che rivangano sia per i riferimenti internazionali che evocano. Pronte ad intercettare il ritorno di Donald Trump che vola di nuovo sul cielo dalla Casa Bianca per farci davvero correre il rischio di finire come un satellite centro-americano, accomunato ai ‘latinos’, con un’Italia allineata agli Stati Uniti e marginale nel quadro decisionale europeo.
Ad occhio sembra che la lunga marcia di restauro della destra italiana dell’idea di Nazione[4] abbia più possibilità di naufragare nella sua dimensione internazionale che in Italia, in cui la seconda Repubblica ha educato gli italiani a digerire anche i sassi facendo metabolizzare l’assioma numero uno di Silvio Berlusconi, secondo cui le istituzioni contano pochissimo e persino lo Stato ha il compito di confezionare con un minimo di ordine ciò che società e mercato producono ‘vitalmente’.
L’apparente legittimità all’appello pressante all’interesse nazionale, che potrebbe anche essere una sorta di leva contro la rilassatezza civica italiana di questi tempi, finisce per non essere pedagogia sociale (a cui manca la vera filiera che aveva il collateralismo radicato dei grandi partiti della prima Repubblica) limitandosi a innervosire le minoranze progressiste perché risveglia fantasmi. Ma dal punto di vista dell’azione di governo questo “interesse nazionale” è maneggiato senza modernità e senza rielaborazione dei contesti di transizione entro cui tale concetto non saprebbe più che pesci pigliare. Tanto la transizione ambientale quanto quella digitale per non parlare di quella scientifico-sanitaria hanno il problema di misurarsi sulla totale capacità di governare la concettualità glocal (cioè, il profilo culturale “a tenaglia” per definizione più anti-nazionalistico che sia stato inventato nel Novecento).
Non esce dal nostro quadro di governo, dalle dichiarazioni dei ministri, dal pensiero spesso somministrato televisivamente dalla premier, nessun accenno di consapevolezza e di padroneggiamento di questo aspetto che invece appare nel linguaggio politico europeo e internazionale. Il fatto che anche l’opposizione navighi in un indistinto populismo emozionale non giustifica che chi governa addobbi di retorica il dibattito sulle proposte in campo senza mai riferirsi alle regole di partite complesse avviate e concordate. Che sono riguardate da una forte revisione dell’impianto culturale del Novecento in cui solo chi è all’opposizione può sbraitare fuori dal tempo e dallo spazio.
Insomma, questo della cultura del gruppo dirigente di Fratelli d’Italia è il terreno di analisi più importante per capire se viene letto e metabolizzato il tempo di cambiamento e adattamento che attraversiamo. Mai come ora esso dovrebbe essere commisurato alle poste in gioco in una creatività di analisi e di soluzioni in cui il concetto di Nazione dovrebbe esistere solo per motivare come misurarsi sui paradigmi di adattamento di una realtà complessa, nelle sue disunità e nelle sue disuguaglianze, come è l’Italia contemporanea. Il successo delle politiche italiane sarebbe allora quello di introdurre le “variabili nazionali” nello studio della messa a terra di scelte che sono valide nei punti alti della competizione e che poi ogni contesto deve riportare a vincoli culturali e finanziari governabili se la propria storia nazionale viene ben padroneggiata soprattutto in senso critico.
Con franchezza non si vedono esempi di questa alta flessibilità. Si vede una produzione seriale di gaffes, tempestate da frasi astute, assertive, comizianti di un capo sotto pressione con l’ansia naturale di conservare un consenso che ha prodotto all’improvviso un enorme fatturato elettorale fondato primariamente sulla debolezza degli avversari.
La declinazione “nazionale” nelle politiche culturali
L’approccio al tema identitario ha fatto parte della trama convegnistica dei primi tempi del governo Meloni. Con il duplice scopo di sottrare alla Lega l’egemonia di un termine usato soprattutto nel nord per rivendicare il carattere plurale delle culture territoriali e la legittimità di governare tradizioni distinte. Ma al tempo stesso di nobilitare il “patrimonio valoriale” rispetto ai caratteri commerciali e paganeggianti del berlusconismo. E soprattutto di riportare al solco della “specificità italiana” tendenze creative, ispirazioni, eccellenze riconosciute, che – soprattutto sul terreno dei consumi culturali – vanno rischiando di diventare “patrimonio di tutti”. Ovvero un patrimonio piluccato da chi egemonizza si direbbe la “post-produzione” di forme creative che appartengono al vanto italiano.
Pur messa così, la materia richiederebbe un’alta abilità di trattamento, sostanzialmente generato dall’idea dello scambio e quindi della contaminazione di processi creativi che rendono difficile e imbarazzante l’appropriazione identitaria di personalità, di narrative, di forme artistiche.
Una campagna “nazionalistica” della Polonia, ad esempio, per rivendicare la “polonesità” di Chopin avrebbe un carattere risibile.
Ebbene questa manovra che si poteva svolgere con il taglio alto – esempio provocatorio – dell’Enciclopedia Italiana degli anni Trenta diretta da Giovanni Gentile, da noi si è espressa con la solita dichiarazione televisiva, nel caso del ministro della Cultura, per mettere un ombrello parafrasato fino all’imbarazzo su questa tematica. Proponendo cioè Dante come padre della destra italiana.
Ha una sua intuizione metodologica avere individuato la rete delle competenze che deve distribuire il piano di sostegno al ribaditissimo “orgoglio italiano”. Rete magari adattata al filo rosso dei ministri meloniani. C’è dentro Cultura e Istruzione, ma anche Turismo, Sport e Made in Italy (Imprese), con la cornice relazionale degli Esteri, quella protettiva di Difesa e Interni e, come per tutto, un accentramento decisionale a Palazzo Chigi con gli snodi degli Affari europei (che ha anche la faticosa gestione del negoziato e della messa a terra del PNRR mentre gli Affari Regionali sono la meno investita trincea di un tema “a perdere” per Giorgia Meloni che è l’autonomia differenziata su cui lascia che sia la Lega a scornarsi per non scoprire il vulnus rispetto a quello che dovrebbe essere il pilastro ideologico dell’orgoglio italiano, cioè l’unità della Nazione.
A ben guardare le affermazioni che scorrono nelle vene di questo sistema arterioso sono per ora più elementi di principio che un vero e proprio “piano” con poste in gioco misurate e con un predisposto controllo efficiente dei risultati. Un esempio per tutti è il “Piano Mattei” che nasce all’insegna della sfida italiana agli altri paesi europei di tradizione colonialista in Africa – come lo fu anche l’Italia – che per ora è annuncio con alcuni spunti. Anche se è comprensibile che i volumi finanziari idonei a passare dall’astratto al concreto richiedono un PIL più robusto e la prioritaria soluzione di altri problemi che urgono (dalla sanità all’agricoltura). Anche i più benevoli commenti, dopo la conferenza italo-africana di fine gennaio, hanno sollecitato il
“cambio culturale nell’approccio politico, dalla tattica alla strategia, dalla reazione alla ideazione”[5].
Qualunque paese moderno avrebbe nell’area del Ministero dell’Economia (dove si governano anche tasse e bilancio) il cuore pulsante di questa trama. Ma qui – al di là di persone e programmi politici – appare finora che l’economia italiana mantiene il suo sguardo basso sul presente, lascia che ci sia una politica di annunci ma poi governa soprattutto la quadratura condominiale, non potendosi permettere il ministro Giancarlo Giorgetti altri frizionamenti dopo quello sul Mes. Siccome l’accentramento praticato da Giorgia Meloni è fatto di molte parole e di un continuo gioco di anticipo rispetto alle competenze dei singoli ministri, finora l’orgoglio italiano appare come una carta velina rispetto al vero processo vascolare del Governo che è quello di una costante microconflittualità e un pesante controllo reciproco tra gli alleati di governo. Con situazioni già viste, generalmente, nei governi di coalizione, ma qui appesantite dalla mancanza di quella cultura dell’eterna mediazione di democristiana memoria che ha tenuto a bada il bisticcio fisiologico delle coalizioni per infiniti anni di storia repubblicana e che ha concorso tuttavia alla ricerca di equilibri per rendere possibile il passaggio storico dai “libri dei sogni” alle riforme[6].
Se fosse ancora accettata l’idea che gli equilibri di potere in Rai sono un buon rilevatore delle tendenzialità del Paese (in questo caso la “nazione” va proprio chiamata così), potremmo fare qui il cantiere per riportare molti argomenti fatti emergere allo scopo di analizzare con più “scopo” se la legittimità di orientamento corrisponde al rispetto del pluralismo primario di un servizio pubblico e se tale orientamento si possa annoverare con un “interesse nazionale”. Alla cultura “statalista” della destra-destra infatti sta bene il campo di gioco della Rai, purché rivoltata come un calzino. Tirando qualche somma ciò che finora si è visto è stato più una tribuna di polemiche di potere meno un’analisi accurata delle conseguenze sul prodotto.
Naturalmente questo cantiere deve comprendere anche le nomine (dicasi “le nomine”, non l’occupazione della Rai!). Ma sarebbe venuto il momento di valutare anche gli sceneggiati messi in produzione, l’impaginazione dei tg, la politica delle scelte cinematografiche, la visione (o la non visione) crossmediale e digitale, l’assunzione di ruolo informativo rispetto alle crisi internazionali (a cominciare da quelle euro-mediterranee). Fino a comprendere per intero quella piattaforma metaforica dell’identità italiana (“autobiografia della Nazione” è stato detto) costituita dal festival di Sanremo.
L’impressione è che la complessità Rai reagisce trasformando ognuno di questi aspetti in un nodo di contraddizioni. Che accentuano il conflitto egemonico e politico. Ma anche comprensibili resistenze e quindi difformità. Sanremo 2024 sta probabilmente al centro di questa conflittualità. Mentre altrove la “mano pesante” ha trasformato alcuni prodotti di tradizione in modo grottesco. Sul punto di “interesse nazionale” invece non c’è nessun passo avanti, ma anzi un arretramento teorico, metodologico e di prospettiva riguardo all’aggiornamento della funzione di “servizio pubblico” che dovrebbe essere la massima preoccupazione della “Nazione” ed è invece a carte e quarantotto per insipienza progettuali, per eccesso di spinte disgreganti e per pochezza della strategia a monte.
Nella declinazione delle “politiche culturali” ci dovrebbe essere un posto in prima fila per il tema “Scuola/Educazione”, rispetto a cui non bastano i cenni fatti all’ipotesi di riorientamento degli insegnamenti “creativi” chiamati con un po’ di propagandismo ‘Made in Italy’ (ci potrebbe essere casomai una tradizione creativa italiana da applicare a contenuti estetici e culturali che appartengono oggi ad una evoluzione planetaria, al di là dei sistemi produttivi che sono diventati per tutti e dappertutto ibridati). Tengo in sospeso un giudizio, non volendo – qui, come credo di fare per il resto delle questioni – prendere a prestito argomenti della polemica politica per assolvere o condannare senza adeguata ricerca di merito. L’impressione – dalla mediatizzazione del problema scuola – è che prevalga l’impuntatura circa il bisogno prioritario di riscrivere un po’ “la storia guastata dal ’68 e dalla cultura del lavoro” (cosiddetta “riforma Valditara”[7], rispetto ad un moderno ripensamento della didattica che – tra tradizioni e innovazioni – assicuri competitività ma anche pari opportunità sociali e adeguata lotta alle dispersioni. Insomma, non appare evidente (come spesso in passato) la priorità strategica del settore. Confido in prossimi approfondimenti di adeguare la valutazione.
Cosa resta da prendere in considerazione?
La marcia dei trattori ha spinto l’analisi della demoscopia politica a tirare un primo bilancio dell’anno e mezzo di governo venendo anche a capo del rapporto tra annunci e risultati di cui si è detto. Giorgia Meloni perde complessivamente sei punti di gradimento e consenso. Mario Draghi, partito più alto di Meloni (68 per cento contro 55 per cento) aveva accumulato progressione nella prima fase di governo, concludendo poi il mandato con solo 4 punti in meno ralla partenza. Giorgia Meloni ha tenuto botta nella prima parte ma è scesa a gradoni negli ultimi mesi (da 55 per cento all’avvio a 44 per cento oggi). Restando tuttavia ancora in testa alla classifica dei leader politici italiani (quattro punti in più dal secondo classificato che è Giuseppe Conte al 40 per cento, con Emma Bonino al 38 per cento, Antonio Tajani al 37 per cento, Elly Schlein al 32 per cento[8].
L’iper-concentrazione su tanti, troppi dossier della premier dovrebbe consigliare l’affiancamento non solo di “figure di fiducia” ma anche di vere e preparate figure di analisi strategica. Quelle che si formano nei percorsi di studio e sperimentazione di tutti i contesti alti della competizione politico-istituzionale, mentre nell’apparato di governo si vedono piuttosto i sodali della prima ora e il solito giro dei condiscendenti consiglieri giuridico-amministrativi che sono il condimento storico della “cucina romana” della politica italiana. Che servono più all’adattamento che alla strategia.
Orgoglio italiano, concetto di nazione e rigenerazione identitaria non sono concetti abominevoli.
In un modo o nell’altro tanti governi di prima e seconda Repubblica hanno messo in bilancio programmatico queste partite, sempre minate dal rischio di un propagandismo più forte del valore aggiunto in termini di risultati comparativi. Il governo Craxi, con forte stabilità per i tempi (4 anni), aveva molti elementi di elaborazione su queste materie, ma con un gruppo dirigente più attrezzato e con una sinergia metodologica e politica con l’Europa, fattori che assicuravano le interdipendenze necessarie. Anche i governi tecnici hanno agito su queste leve (Monti e Draghi certamente). Ma la politica di un tempo aveva il dono di immaginare contenuti dentro questi concetti a rischio di remotismo nostalgico, per un paese in cui la memoria del fascismo non è mai svanita, che si misuravano sulla crescita economica, sugli effetti di coesione rispetto alle disuguaglianze (memorabile la lezione di “orgoglio italiano” attraverso le riforme di struttura del primo centrosinistra).
Qui la mancanza di controllo della capacità competitiva economico-tecnologica genera fragilità strategica evidente. Che finisce con lo schiacciare sul senso di apparenze declamatorie ciò che, provenendo da una forza nata in rottura a destra con il partito di destra a cui apparteneva quando il suo leader (Gianfranco Fini), in via di evoluzione esperienziale, ebbe a dire che il fascismo era stato “un male assoluto”, scelta che ha prodotto una base teorica (le “Tesi di Trieste” elaborate nella convention costituiva di un nuovo partito e mai disdegnate), che alimenta naturalmente il sospetto (in Italia e nel mondo) di appartenere ad un sostanziale programma post-fascista. Sempre ricordando, tuttavia, che, a partire dal discorso di insediamento in Parlamento il 25 ottobre 2022, Giorgia Meloni vanta ormai una serie di affermazioni che fanno parte di quella che è considerata la sua argomentazione a-fascista[9].
Due libri
La comprovazione di questo rischio (divaricazione tra le forme del progetto di ispirazione “nazionale” e il valore aggiunto della sua concreta attuazione) viene sempre dalle fonti primarie dell’agire politico di Giorgia Meloni. Due libri hanno fissato l’avvio del suo percorso e il bilancio alla fine della fase di start-up. Il primo è l’autobiografia parallela al successo elettorale[10], con spunti utili alla analisi ma in sostanza con l’offerta di un concetto chiave dell’accreditamento: la coerenza personale, argomento moralmente interessante ma marginale nella valutazione di attuazione di una cornice ideologica “coerente” con l’azione di governo. Il secondo è la recente conversazione con il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, una sorta di “portavoce” della politica di coalizione che Meloni rappresenta[11], che volendo interpretare il titolo (privo di sottotitoli) punterebbe all’ennesima istanza di dialettica (la “versione”) con la tante fonti critiche (politiche e mediatiche) che hanno obiettato cose alla premier. Fa più testo la parola che apre e chiude la conversazione. Risponde alla prima domanda:
“Il mio primo obiettivo è restituire agli italiani l’orgoglio di essere tali”.
E suggerisce il claim in copertina che chiude il libro:
“Come mi vedo tra dieci anni? Orgogliosa di come ho fatto il mio lavoro”.
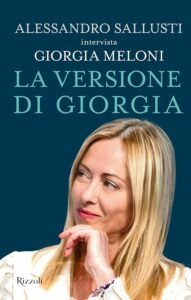
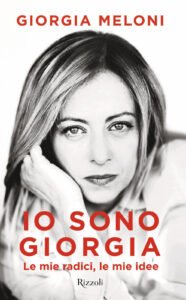
Molto spazio è dedicato nel libro-intervista a rassicurare chi crede che la Meloni sia conservatrice perché ciò finisce a “conservare il passato”. Dice che vuole visione, che vuole guardare lontano, che il fascismo non fa parte del suo ‘campo’. E che il suo ‘campo’ è piuttosto la realtà. La determinazione di queste risposte è perentoria, senza retropensieri. Ma quando poi il cantierino logico si dovrebbe spostare almeno sui paradigmi fondamentali con cui si “fa futuro” esce il grosso della sua argomentazione che risponde – almeno tre su quattro – alla incessante critica alla sinistra: più arretrata, più conservatrice, più passatista di lei. Una volta in più tra il dire e il fare…
In sostanza Giorgia Meloni, come fonte, non ci dà retta rispetto al tema della valutazione matura di un progetto politico-istituzionale di un paese che è nel top-ten del rilievo economico-culturale del pianeta. Ci continua a dare segnali dell’energia, piuttosto, che mette sulla risorsa comunicativa per sostenere immagine e consenso. Eppure, ci sono imprenditori e statisti che una volta buttata lì la pennellata visionaria attivano leve di elaborazione di primaria qualità per battere la concorrenza e far accadere le cose. Forse ce li siamo perse, ma nei due o tre inventari che l’anno meloniano ha obbligato a fare questi ‘piani pregiati’ onestamente non si sono visti.
Forse la contraddizione di Giorgia Meloni è soprattutto quella di percepire questo rischio che ne frena ambizioni e ambito di manovra nazionale e internazionale. Ma non sembra aver trovato finora il modo di prendere seriamente le distanze non tanto da questa o quella parola ma dalla condizione culturale in cui quel modo di fare il combattimento politico ha forgiato in modo non convertibile la generazione e il clan a cui non solo appartiene ma in cui ha domato aspirazioni e contrasti con il metodo classico di chi sceglie l’estremismo come cantiere formativo. Nel suo caso
“pas d’ennemis à droite. Jamais!”[12].
18 maggio 2024
[1] “Giorgia Meloni’s not-so-scary right-wing government”, The Economist 24 gennaio 2024 (Il governo di destra di Giorgia Meloni non fa poi così paura).
[2] Stefano Rolando, “La parte italiana della nuova destra europea”, Mondoperaio, (11) novembre 2022.
[3] Virginia Piccolillo, “Giorgia Meloni: «La nostra identità nazionale, famigliare e religiosa è sotto attacco»”, Il Corriere della Sera, 23 settembre 2023. Occhiello: “La premier è intervenuta a Budapest, al Demographic summit, accolta da Orban. Zan del Pd: «Sta attuando una vera e propria persecuzione verso le famiglie arcobaleno».
[4] Nessuno che nel frattempo si sia letto l’ineludibile lezione di Federico Chabod: si vedano le sue Lezioni di storia moderna: sommario metodologico. L’idea di nazione, Roma, Edizioni Italiane, 1947, LXXXII-90 p. Oggi con il titolo L’idea di Nazione, Roma-Bari, Laterza, 2021, 198 p.
[5] Stefano Simontacchi, “Tre punti per il Piano Mattei”, Il Corriere della Sera, 30 gennaio 2024.
[6] Si consenta su questa rivista il riferimento – proprio in ordine a questo sguardo – al decimo e ultimo volume della serie di volumi di ricerca progettati da Gennaro Acquaviva, Democristiani, cattolici e Chiesa negli anni di Craxi, a cura di Gennaro Acquaviva, Michele Marchi e Paolo Pombeni, Marsilio, 2018, 400 p.
[7] Approvata in Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2023.
[8] L’atlante è di Ilvo Diamanti su La Repubblica del 10 febbraio 2024
[9] Dal resoconto del discorso di insediamento:
“Libertà, dicevamo. Libertà e democrazia sono gli elementi distintivi della civiltà europea contemporanea nei quali da sempre mi riconosco. E dunque, a dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto, non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso. Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. I totalitarismi del ‘900 hanno dilaniato l’intera Europa, non solo l’Italia, per più di mezzo secolo, in una successione di orrori che ha investito gran parte degli Stati europei. E l’orrore e i crimini, da chiunque vengano compiuti, non meritano giustificazioni di sorta, e non si compensano con altri orrori e altri crimini”.
[10] Giorgia Meloni, Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, Milano, Rizzoli, 2021, rieditato dopo l’esito elettorale del settembre 2022.
[11] Alessandro Sallusti intervista Giorgia Meloni. La versione di Giorgia, Milano, Rizzoli 2023, 256 p.
[12] Uno dei tanti riferimenti, la polemica tra Donzelli e Crosetto sul caso Vannacci in Valerio Valentini, “Pas d’ennemis à droite. Il caso Vannacci e i picchiatori picchiatelli di Meloni”, Il Foglio, 22 agosto 2023.














