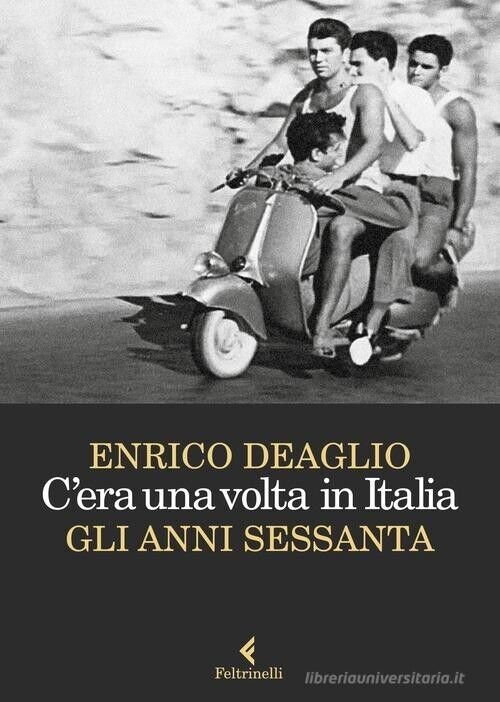A proposito di C’era una volta in Italia. Gli anni Sessanta di Enrico Deaglio[1]
In qualche altra occasione ho mescolato libri e televisione. Perché in verità i due mezzi di comunicazione sono apparentemente nemici (“chiudi la tv e leggi un buon libro”, dicevano una volta moralisticamente gli intellettuali, ma anche commercialmente i librai), ma sono anche attratti da amore e soggezione. I libri bramano ad essere sceneggiati, raccontati, popolarizzati. La tv è orgogliosa del suo specifico narrativo, certamente; ma sa di avere parenti stretti che sono la musica, il cinema e l‘editoria. Faccio anche oggi questa “mescolanza”, pur avendo immaginato da più di due mesi di parlare di un librone immenso, di seicento pagine, che mi ha regalato mia sorella a Natale, e in cui – dopo una sfogliata profonda nei primi giorni – vado avanti con molta ruminazione di ricordi, nostalgie, contrappunti, qualche presa di distanza, per lo più ammirazione per la selezione e per la sintesi. Parlo, con sincera stima, dell’autore, di Enrico Deaglio – a cui si devono libri importanti di indagine storica su aspetti insoluti o semi-insoluti di storia contemporanea (come il caso di Piazza Fontana 1969) – e ora del suo primo tomo dell’annunciata serie C’era una volta in Italia”. Qui edito da Feltrinelli con un bel punto di partenza: Gli anni Sessanta[2]. C’è molto testo, ma tutto scorre con forza grazie a foto e a didascalie. È in apparenza un almanacco retrospettivo. Nella sostanza è una selezione storica dei fatti che hanno cambiato il costume e del costume che ha cambiato i fatti. Quando per fatti intendo la cronaca che si fa storia. E per costume intendo la trasformazione della cultura e dei comportamenti. Avevo scritto sulla pagina di Facebook di Deaglio:
Caro Enrico, ho ricevuto ieri come regalo pre-natalizio il tuo Gli anni Sessanta. Al cui acquisto sarei arrivato anche con le mie risorse. Un magnifico lavoro che mi ha tolto un po’ il sonno, ma pazienza. Ti scriverò a fine lettura per un commento più circostanziato. Sto facendo il bilancio, in peso netto, dello spazio dedicato a Torino rispetto a Milano, temo che ci sarà qualche piccolo contenzioso. Ma leggerò. Quella che qui accludo è – se posso usare una parola esagerata – una poesia che introduceva il capitolo sui ’60 di un mio libro pubblicato con Bompiani nel 2008 con il titolo Quarantotto in cui avevo raccolto tutti i miei scrittini diciamo così “civili” (non quelli professionali o disciplinari). Te li manderò, per omaggio “integrativo”, rispetto alla tua comunque monumentale ricostruzione. Ma qui in poche righe c’è un sentiment. Comunque, molti rallegramenti.
Sono ora alla recensione promessa. Tralascio per ora la mia poesiola (forse ne parleremo un’altra volta, anche se dentro credo ci sia il senso stesso del titolo che ho voluto dare a questo testo, la “doppia anima dei Sessanta”). E liquido anche rapidamente la minuscola punturina. Punturina che, ben sapendo che li divide il Ticino, lombardi e piemontesi qualche volta si fanno a vicenda. Ma qui ci sono grandi attenuanti. Per la nostra generazione (mia e di Enrico Deaglio, io dietro a lui forse di un anno) i “Sessanta” sono una ineludibile mitologia, che corrisponde al passaggio dall’adolescenza all’università, cioè dalla famiglia all’impianto della nostra autonomia: moto, ragazze, sigarette, calcio, ciclismo, cinema, musica e ritmi, politica, estati, luoghi comuni, luoghi fuori dal comune, sé e altro da sé, opzioni profonde per il dopo.
Tutti noi abbiamo in comune i “magnifici anni Sessanta” (per altri l’etichetta è “i favolosi anni Sessanta”). Cito le “etichette” perché il titolo che ho dato a questa nota non le smentisce ma le contestualizza in una meno citata complessità. E ciascuno guarda da uno spioncino interno, con cui vede la supermitologia del proprio vissuto in quel mito. Do per scontato che lo spioncino di un torinese e quello di un milanese differiscono più per quei tempi che per come le nostre città sono diventate. Quindi è normale che i miei anni Sessanta a cui ho dedicato un capitolo del mio Quarantotto[3] siano striati dalla mia nebbia, i miei licei, i miei luoghi di vacanza, la percezione di una borghesia spaccata sul tema dei diritti civili, la cornice della prima fase della liberazione dall’etica industriale (a Milano prima che altrove) e soprattutto l’umorismo apparentemente stravagante del nostro alto cabaret (da Dario Fo a Enzo Jannacci a Giorgio Gaber).
Ha tuttavia ragione Enrico Deaglio a tenere un certo equilibrio nord, con un racconto che privilegia queste due città, in un certo senso un asse nord-ovest, rispetto al resto d’Italia (Roma compresa, a cui toccano pagini cruciali del testo), che pure ha il suo inventario per quel decennio. Ma è difficile dare i resti a tutti. Forse Napoli (ho trovato molto bello il racconto della visita di John Fitzgerald Kennedy nel 1963 poco prima della tragedia di Dallas) appare un filo più attenzionata rispetto alle altre città del centrosud, anche qui ragionevolmente.
Al fondo lo scavo di storie, notizie, immagini, risvolti narrativi rimbalza dappertutto in Italia in quegli anni ma – nella lettura di Deaglio con un traino nord negli anni Sessanta dovuto alla trasformazione che comincia nel rapporto tra sistemi industriali e urbani. Il carattere di rivoluzione continua che gli anni Sessanta assumono è largamente dovuto alla trasformazione di tutto ciò che fa prodotto: dal materiale all’immateriale; dall’automobile al governo del Paese, dalla colonna sonora all’urbanistica; dalle occupazioni universitarie alla scalata delle squadre del nord al mondo.
In dialogo con Augias
Questo pozzo di perle (giornalisticamente parlando) è emerso come un vulcano lento e inesorabile nel confronto potremmo quasi dire intergenerazionale tra Corrado Augias (12 anni più di Deaglio) e lo stesso Deaglio in quel bel programma (La Torre di Babele su La 7) che alcuni di noi avrebbero sognato di inventare e condurre, per parlare – in quel modo, salottieramente e senza troppe remore – di ciò che ha contato nella nostra vita. Luoghi, persone, città. Nella vita, nell’agonia e nella scomparsa di quel sistema di idee e valori che una volta chiamavamo ideologie (picconate dal torinese Norberto Bobbio e bisticciate dal poeta recalcitrante che fu Pier Paolo Pasolini). Nella seconda parte della puntata televisiva Augias ha proseguito lo scavo del decennio in questione con lo scrittore Francesco Piccolo. Ideologie che adesso richiamiamo solo come un passato a cui mancava la fluidità spiegata da Zygmunt Baumann e che avendo quindi a un certo punto accertato la loro morte presunta non abbiamo più ritenuto opportuno rianimarle, rigenerarle, scomporle, riportarle a confronto con le nuove evidenze scientifiche. Preferendo seppellirle in datati cimiteri. Privandole così dei nostri verbi al futuro. Gli anni Sessanta sono quelli che insinuano sia la possibilità di prendere le distanze dai vincoli ideologici; sia la possibilità di trasformare quei vincoli in ossessioni, in pulsioni egocentriche e velleitarie.
Da qui si coglie il primo fondamento della divaricazione delle anime del decennio. Nel dialogo tra Augias e Deaglio (il primo, senza perdere mail suo stile, ma leggermente incombente rispetto a quello che avrebbe dovuto essere solo il ruolo dell’intervistatore, in realtà forse deciso a bancare la sua anzianità – come insegnava alla sua generazione l’etica della goliardia – per ritenere, giornalista con giornalista, il loro diritto alla pari nel giudicare e fare emergere il colore e la verità del comune patrimonio di un decennio indimenticabile. Ecco dicevo, in quel dialogo molto perso nell’immensità dei fatti, dei protagonismi, delle discontinuità (da Carosello a Papa Giovanni XXIII, dai Beatles a Che Guevara, dai nostri club del calcio in vetta all’Europa allo sbarco sulla Luna) non era semplice creare uno schema di interpretazione dall’alfa all’omega della filosofia del decennio. Perché i decenni del Novecento li abbiamo trattati sempre come contenitori chiusi, tutto ricomincia ogni volta e rifinisce dopo dieci anni. Con una prima pagina che archivia il vecchio e si innamora del nuovo. Facile dire che con l’autostrada del Sole si archiviano le autostradine (tutte al nord) del dopoguerra. Facile dire che con il ‘68 si archivia il decennio borghese che fa crescere il ceto medio, per spezzare di nuovo sia la borghesia che la classe operaia. Lasciando agli anni Settanta il compito di fare ordine (nel disordine generale) della doppiezza. Terrorismo, inflazione e disordine. Ma sotto la ristrutturazione profonda dell’economia creando nuova modernità e nuove durezze.
Così gli anni Sessanta preparano questa più avanzata, tosta, livida trasformazione, con un tono più allegro, più scanzonato, trainato dai cantautori e dalle minigonne, dai jukebox e dal sapore di sale inteso come metafora balneare (metafora del primo tempo del decennio, è del 1963; poi scenderanno in campo molti pezzi da novanta, Yesterday è del 1965, Stranger in the Night è del 1966, fino al congedo di quel decennio con Un’avventura di Lucio Battisti). Ma al tempo stesso l’anima riformatrice e di adattamento si scontra su quasi tutto sulle condizioni di potere ancora espresso da forme autoritarie del dopoguerra e quindi da fattori che tornano (come fu poco prima del fascismo) a sterzare in forma antimodernista rischiando perfino di fare una marcia indietro pesantissima. Tanto che, giustamente, Deaglio apre la sequenza (due pagine con grandi foto) dello scontro fra Fernando Tambroni e Sandro Pertini nella Genova politicamente bicefala.

La politica.
Il sentiero della politica conta molto in questo grande libro. Ma contano in parallelo anche quelli dell’impresa, dei consumi, della cultura, degli intellettuali, della carta stampata, della già citata colonna sonora destinata a restare, nelle generazioni protagoniste e anche in quelle successive, come ancoraggio emozionale (leggendo anche in questa colonna sonora il dualismo del tempo, tra il neomelodico e le band che rompono il vecchio ritmo).
Scrive Deaglio – su questo ultimo elemento – nella stessa breve sua presentazione: “Ci dovrebbe essere molta musica in questo kolossal, dalla disperazione di Luigi Tenco al rock demenziale di Adriano Celentano, ai valzer e alle mazurche delle feste dei Gattopardi …Che tempi! Qui c’è spazio solo per bricioline di questa vasta materia”.
Con la gratitudine a Enrico Deaglio per avere messo le carte in tavola per ogni tipo di inventario possibile. E a Corrado Augias per aver fatto un primo percorso di inventario, quello della percezione del profumo di un’epoca mitizzata ma ancora non abbastanza studiata. Snodi oggettivi e risvolti personali del decennio Risfoglio allora adesso le seicento pagine modificando la ovvia ripartizione, facile da capire subito, dell’anno per anno. Provo ad attaccarci qualche parolina di senso:
Si comincia dalla modernizzazione del mondo (la decolonizzazione e i nuovi volti della politica). Poi intrecciate le turbolenze e le speranze che riguardano il declino politico in Italia del “centrismo”. Poi atti avvenuti e atti mancati: la riforma dello Stato, impresa a metà; scuola e sanità, grandi cose.
In cammino il costume e lo spettacolo. Tento l’estrema sintesi: l’estetica al tempo delle minigonne.
Dall’Italia al mondo: dal cambiamento al ribellismo, passando per la mondializzazione della protesta a proposito della guerra del Vietnam, solo per ricordarci che una manciata di anni prima scoppiava la seconda guerra mondiale che cancellava sul nascere ogni ipotesi di protesta. Verso la fine l’inevitabile cortocircuito, tra vecchio e nuovo: il Sessantotto.
Così arriva la fine anticipata del decennio spensierato. Arriva il ’69 e poi la stretta conservatrice (che porta, tuttavia, la grande ristrutturazione della parabola industriale). In realtà questa etichetta del decennio “spensierato” è parte di una percezione “di consumo” dei Sessanta. Perché tra spensierato e drammatico è facile leggere il corso dell’anima divisa. E a questo punto – visto che siamo ancora nell’inventario e il cammino del dibattito sarà lungo – cambio idea. Ammettendo il personale coinvolgimento con un discorso che in molte di quelle seicento pagine risveglia indelebili memorie di vita vissuta.

L’elenco dei segni rossi nelle pagine di Deaglio, per lasciarmi memoria del vissuto personale, è più fitto di quanto mi aspettassi. Qualche esempio.
- Parto da Fausto Coppi, morto nel 1960 ma per me in arrivo a Milano da Bormio nell’ultima tappa del Giro del 1953, visto a 5 anni sfrecciare sulla via Emilia, dove mio papà mi aveva portato ai bordi della strada, alla foto di Sandro Pertini che arringa Genova nel 1960 che ho avuto appesa nella mia stanza dal 1965 in poi.

- Parto dal film Rocco e i suoi fratelli girato anche in Viale Argonne a Milano in cui a 12 anni ho fatto un giorno la comparsa retribuita, all’alluvione di Firenze dove fui nel 1966 tra gli ‘angeli del fango.
- Parto dalle vacanze versiliesi che ci parevano sfrenatelle ma che in realtà stavano tutte nei paletti delle regole borghesi ai boati (violenza, proteste, nuova musica, nuove parole d’ordine) che ci piombarono addosso con la guerra in Vietnam nel 1967.
- Parto dalla meraviglia delle Olimpiadi a Roma nel 1960 (con un quadernetto pubblicato dalla Rai per scrivere ora per ora i risultati, annotato nei dettagli) all’avvio (11 aprile 1961) e allo svolgimento del processo Eichmann a Tel Aviv, seguito ogni giorno, spartiacque della mia formazione.
- Parto dal processo Zanzara nel 1966 che riguardò molto più del liceo Parini ma tutto il sistema scuola-società al modo con cui il 1969, con il suo “autunno caldo” colpì imprese e famiglie connesse all’economia industriale (tra cui la mia famiglia).

Mi è così venuta voglia di dare anche io i miei coriandoli a questo inventario e di leggervela qui la mia poesiola sugli anni Sessanta. Queste brevi strofe separavano in quel mio libro un decennio dall’altro e ce ne sono quindi altre (sugli anni Cinquanta prima e sui decenni successivi poi). Così annotava il poeta (chiamiamolo così, impropriamente) che sapeva di poter essere scambiato con tante cose ma difficilmente con le turbolenze silenziose e rimuginanti dei poeti. Ma quella volta, chissà, preso da struggimenti e forse anticonformismi, provò – a suo modo – a fare un altro, credo diverso, piccolo inventario. Queste le brevi strofe di “Anni Sessanta”, scritte quasi quaranta anni dopo le ambiguità del Sessantotto[4].

[1] Il Mondo Nuovo, 2 marzo 2024. Cf. https://stefanorolando.it/?p=8908
[2] Enrico Deaglio, C’era una volta in Italia. Gli anni Sessanta, Milano, Feltrinelli, 2023, 608 p.
[3] Stefano Rolando, Quarantotto. Argomenti per un bilancio generazionale. Partecipazione, libertà, violenza, ambiguità, Milano, Bompiani, 2008, 668 p.
[4] In Stefano Rolando, Quarantotto. Argomenti per un bilancio generazionale, op. cit alla nota 3, p. 115.