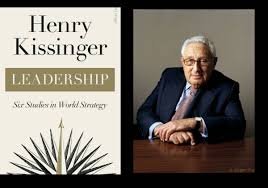Il recente libro di Antonio Funiciello sulla scia di un testimone globale come Henry Kissinger
Il saggio di Antonio Funiciello sulla leadership[1]– accantonato dopo una prima stesura che precedeva il secondo impegno dell’autore a Palazzo Chigi[2] e quindi portato a conclusione dopo il mandato verso la fine del 2022 – editorialmente è in scia con il testo tradotto un po’ tutto il mondo di Henry Kissinger, dell’anno precedente, che aveva come sottotitolo “Sei lezioni di strategia globale”[3]. Ma è in scia anche come posizionamento dello sguardo interpretativo, cioè rispetto alle visuali disciplinari che hanno, potremmo dire modernamente da Max Weber in poi, avuto attenzione per i processi connessi alla selezione del comando. Inteso come complessità di funzioni di guida, fascinazione, influenza, eccetera. Fino – per ragioni di questa complessità – ad interessare diversi rami: la sociologia, pienamente la psicologia sociale, ben inteso il moderno sviluppo delle scienze organizzative, con il concorso di molti strumenti comparativi che coinvolgono storiografia, politologia, geopolitica e – rispetto alle economie emergenti – le scienze della comunicazione e l’analisi economico-funzionale dei modelli di impresa.
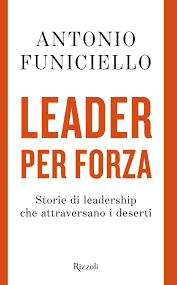
Nel suo Leader per forza – Storie di leadership che attraversano i deserti, Antonio Funiciello – il cui percorso professionale nelle istituzioni nasce nell’ambito della comunicazione e delle relazioni esterne, fino ad assumere ruoli di coordinamento strategico con i presidenti Paolo Gentiloni e poi Mario Draghi, ora rientrato all’ENI con l’incarico di capo dell’area di Identity Management – si colloca nella trasversalità di analisi dei processi politico-istituzionali destinati ad assumere alta responsabilità nella vita collettiva (qui esattamente sulla scia di analisi di Kissinger). Ne fa sintesi questa definizione sintetica:
“La leadership significa farsi carico dei destini della comunità, e la sostanza non è molto cambiata, il significato è questo fin dai tempi di Pericle e forse prima”.
Il testo è scritto in modo brillante. Il disvelamento dell’approccio pragmatico, mai completamente dichiarato, capace di ascolto e di sintesi, dell’azione quotidiana – al coperto – di Mario Draghi è rilevante sul tema oggi dibattuto di far funzionare le istituzioni sostituendo questa analisi all’oziosa e ipocrita distinzione tra governi tecnici e governi politici.
In ogni caso la focalizzazione del testo è sulle figure di grande rilievo istituzionale, non sulla formazione politica bottom up alle prese con l’emersione nella lotta di base del potere. Sono figure già con tutti i tagliandi fatti. Focalizzate nella fase finale del loro percorso di responsabilità e alle prese realmente con i destini della comunità. Insomma, sommando i casi trattati da Kissinger e Funiciello, è ben delineato l’approccio a uomini e donne che hanno fatto la storia, non semplicemente la cronaca. La sociologia politica pura si appassionerebbe di più alle fasi di formazione basilari di quelle figure.
Con questo approccio – stando ai contemporanei – l’indagine avrebbe potuto comprendere percorsi interessanti e forse poco studiati, come quelli di Amintore Fanfani o di Bettino Craxi. In cui senza il cursus honorum – e il senso di appartenenza all’identità dei partiti politici – poco si capirebbe dell’azione istituzionale nazionale e internazionale, ancorché essa ebbe la sua quota di rilevante discontinuità (così come si coglie oggi nell’indagine quotidiana millimetrica su Giorgia Meloni che è alle prese con simili trasformazioni).
Funiciello li racconta già grandi, forti, potenti, stagliati. E da lì ne analizza la capacità magnetica e strategica. Anche per coglierne i limiti (come è il caso della parte del testo dedicata a Angela Merkel pur riconoscendole punti di forza di percorso). Da questo punto di vista tanto il saggio di Funiciello quanto quello di Kissinger hanno sicuro rilievo per la ricostruzione storica del destino delle identità nazionali, in particolare quelle (per altro minoranza dei casi, ma il racconto su Draghi torna a più riprese) nella fase storica della globalizzazione e quindi del cambio pressoché integrale dei paradigmi.
Vanno tuttavia meno a fondo circa l’analisi della crisi di leadership nella lotta politica del nostro tempo e soprattutto nell’involuzione pressoché diffusa della qualità della politica espressa dalla mancata rigenerazione (con evidenza in Italia) dei partiti politici. E ancora: in entrambi i casi la serie delle scelte storiche si staglia nello scaffale di un pluralismo virtuoso.
Quando, storia antica a parte, il Novecento internazionale ha in primo piano leadership potenti, autoritarie e antidemocratiche, i cosiddetti “dittatori”. Storie tuttavia radicate in un vasto consenso popolare e con la formazione di classi dirigenti, servili sì ma anche parte del consolidamento della leadership, la cui analisi ha migliaia di pagine scritte ma poche sono andate a fondo sulla componente viziosa della fascinazione dei capi. Mirabile e svolta in epoca critica l’interpretazione del tema fatta da Charlie Chaplin[4].
Leadership tra consenso e reputazione
Al tempo stesso questo testo in particolare offre spunti anche agli ambiti disciplinari che studiano un fenomeno inter-fattoriale come la leadership per generare prove e controprove molto utili.
In cui l’efficacia rispetto alle soluzioni di problemi di interesse generale (sociali ed economici) ha un quoziente molto riabilitato rispetto all’efficacia connessa al solo consenso. Il consenso è il fattore che più mobilita studi che hanno a che fare con la trasformazione della comunicazione politica e con il rapporto tra spiegazione e propaganda nella politica internazionale del Novecento (e le eredità di queste contrapposte tendenze).
Un consenso che non viene derubricato come tema della leadership. Ma che nel caso di Mario Draghi non aveva a che fare strettamente con il voto ma con il rapporto di secondo livello con le rappresentanze parlamentari. E nel caso di Paolo Gentiloni si rapportava all’agenda quotidiana in una forma forse più sterilizzata, in un certo senso più asciutta e tecnica rispetto a quella esercitata (stesso partito, stessa epoca, stesso percorso di formazione politica) da Matteo Renzi.
Merito del saggio Leader per forza – buon contributo cognitivo sulla trasformazione del rapporto tra politica e istituzioni – è comunque quello di riportare nell’agenda del dibattito politologico e civile la parabola della leadership nella storia italiana come storia di una lunga rigenerazione economica, morale e reputazionale dal crollo del Paese e delle sue istituzioni l’8 settembre del 1943.
Con i suoi interpreti, i loro percorsi personali e di appartenenza, la loro relazione con il cambiamento della domanda e dell’offerta di qualità del comando nella nostra vita pubblica. Anzi, il nitido ritratto di Cavour anticipa i chiarimenti sul ruolo dell’intuizione e della tessitura strategica agli albori stessi dell’unità d’Italia come elemento fondante dell’esistenza stessa dello Stato-Nazione.
Ma, come detto, resta in ombra il trattamento del declino stesso della leadership strategica, descritta – citando Guido Gili e Massimiliano Panarari[5] – come arte sorretta dalla “reputazione costituita dalla credibilità provata”. In poche parole, il tema della crisi della qualità della classe dirigente che contiene anche l’assottigliamento preoccupante di figure capaci di contendere la leadership a parità di reputazione nazionale e internazionale e di riconoscimento da parte almeno della maggioranza relativa dei cittadini.

In parallelo anche il tema della riduzione del perimetro (quantità e qualità) della leadership di impresa in un paese con imprenditori di talento e creatività ma che hanno ridotto le dimensioni competitive al relativamente piccolo ambito delle “medie imprese”. Resistendo solo un piccolissimo gruppo di aziende nel campo delle grandi aziende globali.
L’indagine annuale di Demos sulla reputazione delle istituzioni ci dice che l’unica funzione al riparo da questa decrescente fiducia dei cittadini è quella del Presidente della Repubblica. Non è un caso che nel corso dei mandati dei presidenti Napolitano e Mattarella lo stesso Parlamento per due volte non è stato nemmeno in grado di fare una scelta nuova, dopo i loro primi mandati, rifugiandosi nel rinvio attraverso una inusuale replica dell’incarico.
Naturalmente la lettura di testi di testimonianza (conosciuti personalmente) e analisi (studiati) – come è nel caso sia di Funiciello e ancor di più di Kissinger – hanno l’utilità di far discendere parametri di classificazione da una casistica maiuscola. Ma producono anche la frustrazione di vedere ormai, per esempio in Italia, la rarefazione di quelle esperienze. Un’evaporazione di modelli, una sostituzione di leadership-lampo regolate dal potere cinico dei media che creano e distruggono la visibilità in relazione alla teoria del “trending topic”, che da noi si chiama poi “l’aria che tira”. Quindi in un quadro regolato dal fattore più antitetico alla vera leadership: il presentismo.
Oltre a tutto i trattamenti di cui si parla non sono solo rivolti all’elogio, ma anche alla valutazione delle criticità. Dunque, contengono anche elementi utili per la rivalutazione paradigmatica. Per esempio, a proposito di una delle figure forti nella leadership interna in Europa, quella di Angela Merkel, come ho accennato prima, Funiciello individua zone d’ombra:
“Per Angela Merkel la mia definizione è di leadership irrisolta. La cancelliera non è riuscita a trasferire questa sua capacità di governare bene la propria democrazia su scala più ampia, non è riuscita a rappresentarsi pienamente come leader occidentale. Non aver pensato la guida della Germania anche in chiave extra nazionale è stato un suo limite. Non può non pesare la vicenda russa, l’appeasement tedesco verso la Mosca non ha giovato, esso si fondava sul principio che bisognava tenere Putin vicino, ma a furia di accettare l’aggressività del Cremlino siamo arrivati all’invasione dell’Ucraina con i carri armati”[6].
In Italia nell’età delle transizioni-lampo
Con questi punti di partenza è possibile fare qualche ulteriore considerazione, diciamo riservata alla parte più critica circa le condizioni attuali della leadership nella politica italiana ed europea.
La prima considerazione riguarda l’evoluzione della leadership (tema trattato da Henry Kissinger nel suo testo) nel rapporto tra quadro dei poteri economici e politici e quadro sociale.
È chiaro che la legittimazione della leadership non viene solo dal bisogno di configurare poteri attivi. Ma anche dal bisogno sociale di avere riferimenti, guide tendenziali, qualità profetiche, rassicurazioni sul futuro.
Dunque, questi testi che si riferiscono ai livelli alti e riconosciuti di leader politico-istituzionali hanno un complemento oggettivo in quella letteratura sociologica connessa alla fortuna e all’utilità della leadership nell’arte, nella creatività, nella produzione, nei diversi campi della rappresentazione e della rappresentanza.
Non è per tutti un eterno Rinascimento. Scuole, ascensori sociali, qualità della formazione, stimolazione della libertà di pensiero e di parola, ricerca delle condizioni di cambiamento, sono tutti fattori e ambiti attualmente in discussione, che fanno (o non fanno) delle nostre società i bacini naturali di legittimazione del ruolo guida di alcuni selezionati da quei contesti. E che, in qualche modo, il mercato ha il potere di reiterare o sanzionare.
La società è insomma la base di legittimazione di un ruolo complessivo esercitato nell’ambito di diversi poteri. Che, nel campo politico-istituzionale, assume la configurazione delle libere elezioni (anche il voto è un atto di acquisto). Dunque, il legame, la connessione, la permeazione sociale sono fenomeni importanti per capire la curva tendenziale della leadership.
Cosa che ci fa capire che la leadership non è propriamente un sistema proprietario né tantomeno ereditario. E che ci fa anche riconoscere che la condizione di leadership che si esprime oggi parlando di leadership sociale, non è tra le più fortunate della nostra storia moderna e contemporanea.
Al pari si coglie diffusamente che la leadership tendenzialmente morale e magnetica (la più recente potrebbe essere considerata quella di Barack Obama) – per spostarci su un’altra area immateriale dell’analisi – è diventata cosa rara in quasi tutti i paesi occidentali. E ciò per l’evidente crescita di peso che il denaro ha avuto nella trasformazione delle società dall’economia industriale all’economia finanziaria, così da distanziare in modo non più dialettico l’influenza del denaro rispetto all’influenza della filosofia. Oppure pensando di controllare attraverso il denaro non solo la proprietà ma anche il flusso carismatico (da Silvio Berlusconi a Donald Trump) che può, così come evidentemente anche non può, essere connesso.
La leadership ha assunto in definitiva un carattere ibrido, in cui qualità immateriali e caratteri incidenti rispetto al cambiamento materialistico dei valori devono ormai contemperarsi.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di evitare di trasformare la leadership in puro esercizio del necessario comando. Cioè, sarebbe importante non abbassare la soglia concettuale della leadership da rango carismatico a rango operativo.
Ma per questo alcune condizioni andrebbero salvaguardate e in qualche modo ripristinate, perché in grave declino. Una di queste è il rapporto ineludibile (e invece sempre più eluso) tra politica e cultura per consentire alla leadership di esercitarsi proprio con la tensione di cui parla Funiciello: una fervida interpretazione della storia e una originale visione del futuro.
Ma gli stessi custodi della memoria (gli storici) tendono spesso a dare più importanza a chi vince le guerre che a chi si scervella per migliorare il mondo. Se è concesso un pensiero sulle vicende italiane del Novecento, chi ha avuto le maggiori qualità riguardo a questa tensione (si prenda il caso di Francesco Saverio Nitti) è poi risultato spesso tra i più trascurati, poco studiati e diseredati tra le figure che hanno caratterizzato il secolo.
Alla lunga la democrazia competitiva praticata dai partiti politici (quelli costituzionalmente immaginati espressione di “democrazia interna”) ha fatto emergere il terreno dissimulato ma terribilmente incidente della formazione dei leader politici in quell’espressione estrema, che molti considerano realistica, coniata da Rino Formica che ha parlato – pensando alla prima Repubblica – di “sangue e merda”.
Siamo qui lontani chilometri dalle sale damascate in cui è collocata la scenografia delle leadership istituzionali analizzate da Kissinger e da Funiciello.
Siamo, cioè, entro le regole del controllo delle risorse finanziarie e della gestione del voto espresso da cui è sempre più difficile prendere alcune distanze nella definizione del comando. Si è caso mai potuto assistere all’avvento di figure (non sempre, non in tutti i partiti) capaci di tenere in equilibrio le condizioni reali e le condizioni ideali per l’esercizio del comando. In ogni caso anche le filiere dei gruppi dirigenti sono coinvolte in questo schema. L’equilibrio tra figure dedicate al perfezionamento della vision e filiere dedicate a tenere attive le condizioni materiali stesse della rappresentanza sono affiancate anche nelle vicende istituzionali.
A volte nemmeno frequentandosi, altre volte “conflittuando”, altre volte ancora trovando nella capacità di un “capo” un fattore di coesistenza e quindi di reciproca garanzia che, in qualche occasione attraverso questo equilibrio, ha allungato persino il tempo di permanenza al potere.
Questa storia risulta vera per quasi tutti i partiti della storia repubblicana italiana e per la gran parte delle condizioni di sviluppo della democrazia occidentale. A dimostrazione che i pilastri della leadership politica hanno una natura ibrida.
Così che la mediazione dei conflitti naturali tra le filiere di esercizio del comando e delle responsabilità è diventata anche una competenza trascurata dai manuali, lontana dal diritto amministrativo, marginale nella filosofia politica ma centrale nella consistenza di quella qualità del comando che chiamiamo “leadership”. Nella rilettura delle biografie delle figure più in vista della politica europea del Novecento questa situazione è spesso descrivibile come una schizofrenia incorporata nella stessa personalità del leader.
I casi sono moltissimi, studiati come patologie, in realtà espressione di una sorta di “arte” che ha sempre fatto della politica “arte tragica”. Cioè, la convivenza permanente con i due paradigmi più discussi dall’etica: la teoria del male minore e la teoria della selezione fondata sui punti intermedi, non sulle eccellenze.
Tutte le degenerazioni di questo chiamiamolo così indicibile rapporto, che Tangentopoli fece esplodere con l’ipocrisia di regolare conti e non di fare nuove e adeguate regole, sono all’origine della crisi peggiorativa di sistema della cosiddetta “seconda Repubblica”.
L’istituzionalizzazione che il voto democratico fa della politica intesa come lotta ideologica e di consenso apre naturalmente scenari trasformativi. A volte netti, a volte lenti e dissimulati. L’esercizio centrale del potere che la Democrazia Cristiana aveva esercitato nel corso della prima Repubblica, ereditandolo dalla costante politica liberale dell’età post-risorgimentale (non casualmente con due figure simili che ne riassumono i caratteri, quella di Giovanni Giolitti e quella di Aldo Moro) portava in dote questo carattere di perenne mediazione, trasformandosi in fattore di tenuta e di durata. Ma anche l’evoluzione culturale della sinistra di governo (e oggi naturalmente della destra di governo) rappresenta una storia di esperienze interessanti per capire la tenuta stessa della democrazia. Anche nel suo “relativismo”.
Dal quadro politico a quello istituzionale
Cambia qualcosa, ma non tutto, trasferendoci (così come l’esito del voto obbliga sempre a fare) la centralità della scena dai partiti alle istituzioni.
Due snodi che hanno fino a un certo tempo qualificato la leadership nelle istituzioni sono stati il rispetto sostanziale per la filiera delle responsabilità amministrative (modello europeo) – che si esprimeva nella logica, andata a farsi benedire con la seconda Repubblica, del “io propongo, tu decidi” rivolta dal funzionario al politico – e la capacità anche qui sostanziale (senza perdere la tensione riformatrice e di bisogno del cambiamento) di indossare il principio che la legge è un canone non un limite.
I veri leader istituzionali hanno per lo più poggiato su questi due caposaldi dell’azione quotidiana ma collocandola nell’originalità di una strategia (storia e visione) e con la qualità dei loro gabinetti.
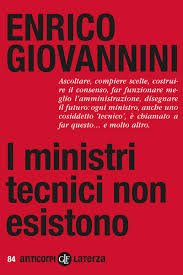
Da questo punto di vista, parlando del governo del Paese, l’idea di distinguere governi tecnici e governi politici, come accennato, perde un po’ di senso. Si veda in proposito il razionale trattamento della questione che ne fa, con saggio ora in uscita, Enrico Giovannini[7]. La natura politica non è il Curriculum Vitae del premier, è il controllo e la legittimazione dell’azione di governo, mai venuta meno. Perché rimasta in capo al Parlamento.
Fa distinzione, appunto, solo il tema dell’appartenenza del leader. Nei casi che si conoscono (Ciampi, Monti, Draghi) la non appartenenza si è rivelata piuttosto utile non solo all’azione del governo ma anche al raffreddamento e alla potenziale riqualificazione delle forze politiche (che talvolta hanno colto, altre volte non hanno colto l’opportunità).
Queste osservazioni sono fatte per altro nella consapevolezza che sia l’amministrazione sia la qualità legislativa hanno subito negli ultimi trent’anni una grave, forse gravissima, involuzione. Quindi ci si può esprimere solo con un pensiero modellistico e con la speranza di reali inversioni di marcia.
L’invasione della politica, spesso inesperta, nei ruoli delle amministrazioni (una delle conseguenze dell’infausto e demagogico provvedimento di cancellazione del finanziamento pubblico ai partiti), ha prodotto tracimazioni (nei settori comunicativi e relazionali si tratta di una quasi completa occupazione) e ha agito come un’ulteriore dequalificazione.
In ogni caso l’esperienza Draghi – limitando almeno alcune di queste malattie – ha mostrato che la crescente cultura di concepire la leadership come visibilità e comunicazione – e poco altro – ha, grazie a comportamenti graditi ai cittadini, rallentato questa deriva. E ha rimesso in pista la complessità dei fattori che compongono il concetto. Tra l’altro spostando – con la stessa architettura di quel governo, tra gestione dell’ordinario e gestione della transizione – l’annuncio del vero tema politico dell’Italia ora: preparare l’ingresso nella “terza Repubblica” o terzo tempo della Repubblica[8].
L’espressione è ancora rara. Non solo nella politica rappresentata ma anche nel laboratorio della nuova politica. Pur vedendo che c’è chi sta abbandonando l’eccesso di nostalgia per la prima Repubblica ma anche l’eccesso di superficialità e autoreferenzialità della seconda.
Nell’ordine del giorno di questa tensione ancora debole ma esistente il tema della leadership non dovrebbe rivolgere troppo gli occhi indietro, ma assumere soprattutto la voglia esplorativa della rifondazione concettuale della materia. Il saggio di Antonio Funiciello offre certamente strumenti e spunti di riflessione, anche riferendosi con audacia al suo quadro di paragoni, dalla Bibbia alla guerra in Ucraina.
Nel guado. Nuovi orizzonti?
Allargando il teatro di questa indagine sulle trasformazioni anche alla creatività che la società esprime attorno alla crisi civile, c’è molto da apprendere (chi non ha individuato spiragli di riflessione a fronte di narrative come il recente Oppenheimer?), così da non far discendere lo sviluppo del dibattito sulla leadership solo dai contesti dell’evoluzione dei modelli del diritto pubblico o dell’incidenza della globalizzazione sulla fortuna di fare impresa.
Una cosa è chiara. Prescindendo dalle teorie pre-industriali e comunque pre-digitali, che governavano un mondo finito, attorno alla leadership, le grandi transizioni contemporanee hanno ovviamente cambiato alcuni connotati modellistici. Lasciando però ai processi attuativi il potere di attribuire questa funzione (o questo carisma) a buoni e cattivi, saggi e manipolatori, autoritari e condivisivi, riformatori e immobilisti. Addirittura, ammettendo come valide le categorie attuative di espliciti e impliciti.
Nella palude vaga e ascientifica dell’evoluzione politica italiana recente, il ritorno delle lodi al ruolo della leadership sottende l’auspicio che si arrivi oggi a una ridefinizione di questa categoria della necessità, un tempo si sarebbe detto anche della passione. E si indica quindi il fattore della “forza”. Diciamo per forza, cioè per necessità. Non con la forza, che implicherebbe nessi ben lontani dalla connotazione democratica.
Ma questo bisogno, questo auspicio che si fonda sulla necessità della funzione (espressione comune a Kissinger e a Funiciello) a fronte dei caratteri stessi delle dinamiche dell’identità competitiva, ha da confrontarsi con un macigno: la piega sistemica delle cose che appare dominata dall’eccessiva fragilità della conduzione valoriale e dall’eccessiva forza della conduzione comunicativa (che si spaccia quasi sempre per valoriale).
Così che – un solo esempio per tante situazioni – una Leopolda ha trasformato un piccolo pianeta umano in “tutti amici” per avere frequentato due giornate di liete rimpatriate. Ed è già meglio della fraternità digitale, in cui la marea dei click ha decretato nuove false orizzontalità che non sono nate nella “traversata nel deserto” di cui parla Funiciello ma nella fulminazione di un social pervasivo.
Non rivendico alla società del tranvai e del ritiro in convento l’unico diritto di formare comunità e quindi leadership. Dico solo che non si deve esagerare sulle leadership della parlantina a cui poi non corrisponde la saggezza della gestione di equilibri scomodi (che riguardano i partiti come le istituzioni come le imprese) in cui il governo dei conflitti è retto da un’equazione ineludibile. Da intendersi come studio più reputazione più controllo degli egocentrismi.
Che i soggetti politici che prima o poi sostituiranno quelli spiegazzati dalle crisi che abbiamo conosciuto debbano per forza avere carattere “leaderistico” è argomento che ha poi qualche tratto ancora da discutere.
Certo devono esprimere una forma certa di conduzione e sarebbe bene che questa conduzione avesse i caratteri di chi davvero coniuga seriamente passato e futuro. Ma soprattutto si dovrà rivedere l’idea che bastano le qualità comunicative a generare una guida, laddove questo parametro ha prodotto più vele al vento che solidi timoni.
E nemmeno bastano le infinite declinazioni (Google contiene 830 milioni di file che pretendono di fornire interpretazioni concettuali) che puntano ad individuare la leadership nel potere di convincere gli altri, che è una definizione in sé passabile ma attraverso cui però passa anche l’inaccettabile.
Dunque, percorsi di affinamento e di compatibilità in cui tutti i caratteri costitutivi (dalla ragione alla passione) troveranno maturazione non dico lenta ma sperimentata solo a certe condizioni.
Questo carattere diventa “da terza Repubblica” (o la si chiami come si vuole, dato che l’espressione è impropria) quando respinge ogni luddismo, cavalca ogni innovazione possibile, guarda al mondo come un’opportunità e non come un pericolo, dunque capace di vivere il proprio tempo.
Al termine del suo testo Henry Kissinger intitola il passaggio evolutivo “Dalla aristocrazia alla meritocrazia”. È un passo non irrilevante. Ma l’altro è connesso al ritorno alla formula democratica dell’organizzazione dei partiti rappresentati, liquidando i partiti personali, quelli con liste fantoccio, quelli concepiti come tasselli di copertura elettorale di alleanze che si disfano il giorno dopo, eccetera.
Cioè, il ripiegamento del marketing, ora bussola di ogni cosa, a una delle funzioni ancillari della politica, con il ritorno della politica alla regia che governa comunità umane non piattaforme che ormai producono più astensioni che elettori.
Il ritorno della leadership, insomma. Precondizione di una ricucitura tra istituzioni e società.
Personalmente non voto contro. Ma pongo il tema del cambiamento meno probabile partendo dal punto di avvitamento attuale del nostro sistema politico. La prova del fuoco. Che posso immaginare che l’ex-capo di gabinetto di quella fase di governo che per un po’ è stata chiamata “i silenzi di Draghi” possa condividere.
Quale paradigma? Ovviamente: tasso di propaganda: zero!
19 ottobre 2023
[1] Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti, Milano, Rizzoli, 2023. Con l’analisi dei casi (oltre a Mario Draghi, trattato nell’Introduzione) di Mosè, Golda Meir, Truman, Cavour, Mandela, Havel e Angela Merkel (nelle conclusioni).
[2] Capo di gabinetto con Mario Draghi, dopo esserlo stato con Paolo Gentiloni.
[3] Henry Kissinger, Leadership. Sei lezioni di strategia globale, Milano, Mondadori, 2022. Con l’analisi dei casi di Adenauer, De Gaulle, Nixon, Sadat, Lee Kuan Yew, Thatcher e le conclusioni dedicate all’evoluzione della leadership.
[4] Il grande dittatore (The Great Dictator) è un film statunitense del 1940 scritto, diretto, musicato, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ebbe cinque candidature all’Oscar.
[5] Guido Gili, Massimiliano Panarari, La credibilità politica. Radici, forme, prospettive di un concetto inattuale, Venezia, Marsilio, 2020
[6] Nell’intervista a cura di Francesco Maselli, per il magazine legrandcontinent.eu del 22 giugno 2023, “Lo stile Draghi. Conversazione con Antonio Funiciello”. Cf. https://legrandcontinent.eu/it/2023/06/22/lo-stile-draghi-una-conversazione-con-antonio-funiciello/.
[7] Enrico Giovannini, I ministri tecnici non esistono, Roma Bari, Laterza, 2023, 296 p.
[8] Espressioni che hanno sempre il beneficio di inventario perché, allo stato, la “terza Repubblica” ha un riferimento univoco, cioè la Troisième Republique, forma dello Stato repubblicano nato in Francia dopo la sconfitta di Sedan (1º settembre 1870) durante la guerra franco-prussiana, che sostituì quella del Secondo Impero, durò in Francia per quasi settant’anni, fino all’invasione tedesca del paese del 1940, sostituita dal regime autoritario del cosiddetto Governo di Vichy.